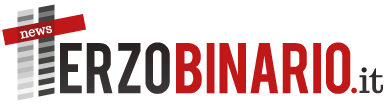di Ginevra Amadio
Roland Barthes è una di quelle figure ammantate da un’aura di ambiguità che nemmeno la morte ha saputo dissipare rendendola stabile. Anzi, per uno strano gioco dei contrari che spetta in sorte – stavolta in misura minore – a certi individui, la tragica fine dello studioso francese (investito da un furgoncino all’uscita del Collège de France) non ha fatto altro che polarizzare ancora di più le posizioni sul suo conto, manicheisticamente divise tra adoratori e detrattori, accomunati comunque, anche in maniera involontaria, da una sorta di spirito barthesiano che più che uno spettro si configura come un demone. Pervasivo e agente, al pari del grande critico.
Appare chiaro, dunque, il grande entusiasmo che accompagna ora l’uscita di Non si riesce mai a parlare di ciò che si ama (Mimesis, a cura di Augusto Ponzio, pp. 50), l’ultimo testo dattiloscritto da Roland Barthes trovato inserito nella sua macchina da scrivere all’indomani della morte. Si tratta di un intervento previsto per il convegno Stendhal a Milano, tenutosi tra il 19 e il 23 marzo 1980 per celebrare l’amore dello scrittore francese per l’Italia, in particolar modo per la città meneghina.
Ma l’amore, come ricorda Barthes in Frammenti di un discorso amoroso, «è sempre raccontato». «[a] Francesca da Rimini e Paolo Malatesta scoprono di amarsi leggendo gli amori di Lancillotto e Ginevra. [b] Werther legge Ossian a Charlotte e questa lettura porta al culmine la passione dell’uno, l’emozione dell’altra. L’amore viene dal libro, l’amore è prima di tutto scritto. Io non faccio che riscriverlo, all’infinito: non saprei che desiderare, non saprei che fare, senza libro che mi guidi. Incontro sempre un libro che dà corpo (linguaggio, racconto, emozione) al mio desiderio».
Si ama perché si sono avuti dei libri, giacché l’universo strutturalista è un mondo di libri e non contempla più, come nel realismo, il libro del mondo. È l’intertestualità, figlia diretta della morte dell’autore, l’impossibilità, per la letteratura, di avere alcun tipo di referenzialità se non la letteratura stessa. Sembra di muoversi all’interno della Biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges, spazialmente infinita e per questo senza via d’uscita alcuna.
Per Barthes «l’artista non pone affatto la “realtà” all’origine del suo discorso, ma solo e sempre, per lontano che si possa risalire, un reale già scritto […]». Così affermava in S/Z e così ritroviamo ne Il discorso amoroso, dove fa capolino costante «il grande Libro anonimo del Linguaggio», «libro [che] comanda al linguaggio degli affetti, all’affetto come linguaggio». E sappiamo bene come il linguaggio, impersonale e anonimo, abbia preso, per Barthes il posto antico e ingombrante dell’autore come persone psicologica e – perché no – borghese.
Ecco allora che parlare dell’amore di Stendhal per l’Italia lo porta ad indagare i libri dello scrittore francese, con un’ottica certamente vicina al testo come lo strutturalismo andava comandando; sono i Diari, le Passeggiate romane e Naples et Florence a interessarlo ma, più di ogni altro scritto, è la Certosa di Parma a rivelare, per lui, il coup de foudre stendhaliano. Un romanzo «scritto vent’anni più tardi, per una specie di scoppio ritardato, di après-coup».
È l’idea che l’amore abbia bisogno di una certa distanza per essere raccontato. Anche quando all’origine vi è sempre un amore già scritto. «Il Libro d’amore non è pedagogico; non insegna a fare l’amore, esso è magico: esso induce a farlo esistere, ha la funzione di una formula operativa, che consiste nel condurre la forza dalle parole agli atti; il Libro è passaggio al reale, acting-out: il bacio nasce dalla carta e viene a posarsi sulle labbra di Paolo e Francesca (la carta – riparo, distanza, decenza, irrealtà, controllo, censura – è rivoltata: il simbolico che trasgredisce il libro è trasgredito)».
Ed è forse, se vogliamo, un involontario richiamo all’antica funzione della letteratura come apprendistato alla vita: ci innamoreremmo se non avessimo mai letto una storia d’amore? Parlare d’amore è un po’ vivere e un po’ raccontare. Non c’è manicheismo che tenga,del resto, laddove il sentimento, e la letteratura, si presentano costantemente come i territori privilegiati della via di mezzo.